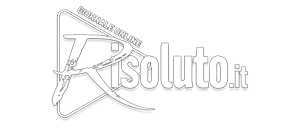Sono passati trentatré anni dalla strage di Capaci. Quel giorno, il 23 maggio 1992, sull’autostrada A29 nei pressi di Capaci, persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e collega Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.
Giovanni Falcone è stato il magistrato che ha dato un contributo decisivo alla comprensione e al contrasto di Cosa nostra. Le sue indagini hanno aperto nuovi scenari nella lotta alla criminalità organizzata e cambiato in modo duraturo il modo in cui lo Stato ha affrontato la mafia. Grazie al contributo di numerosi collaboratori di giustizia, a cominciare da Tommaso Buscetta, Falcone è riuscito a delineare l’organizzazione interna della mafia, ricostruendone la struttura gerarchica e individuandone mandanti ed esecutori.
Insieme a Paolo Borsellino e agli altri magistrati del pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto, ha istruito il maxiprocesso di Palermo, che ha portato a giudizio 474 imputati. Un processo che ha rappresentato un passaggio storico e un punto di svolta nella lotta alla mafia. Fondamentale, in quegli anni, fu il metodo investigativo sviluppato dal pool: seguire i flussi finanziari, colpire i patrimoni, ricostruire i circuiti economici e politici in cui la mafia si muoveva.
Falcone aveva ben chiaro che il potere mafioso si estendeva oltre la violenza, radicandosi in settori dell’economia e delle istituzioni. Una consapevolezza che si tradusse in una strategia giudiziaria capace di mettere in crisi i vertici mafiosi. La mafia reagì con un’escalation di violenza che assunse tratti eversivi. In quegli anni furono assassinati magistrati, giornalisti, rappresentanti delle forze dell’ordine, esponenti politici come Piersanti Mattarella, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio La Torre. Quest’ultimo fu promotore di una legge fondamentale, approvata solo dopo la sua morte, che introdusse il reato di associazione mafiosa e il sequestro dei beni.
Il maxiprocesso fu una delle risposte più forti mai date dallo Stato. L’impianto accusatorio, sostenuto da testimonianze e riscontri, resse fino in Cassazione. Ma proprio la forza di quella sentenza aprì una fase ancora più drammatica: la stagione delle stragi. L’omicidio dell’onorevole Salvo Lima fu il primo segnale. Secondo la magistratura, Lima era un riferimento politico della mafia. Fu eliminato perché non riuscì a influenzare l’esito del processo. La sua morte segnò anche la fine della candidatura di Giulio Andreotti alla Presidenza della Repubblica.
All’epoca dell’attentato, Falcone ricopriva un ruolo chiave al Ministero della Giustizia, come direttore degli affari penali. Da quella posizione lavorava all’elaborazione dei principali strumenti normativi antimafia. Fu anche il promotore della Direzione nazionale antimafia, che però non riuscì mai a dirigere. Il suo percorso fu ostacolato da resistenze e attacchi sin dagli inizi, quando – dopo un breve incarico alla sezione fallimentare – cominciò a occuparsi di criminalità organizzata.
Nel suo lavoro incontrò spesso ostilità. Fu colpito da lettere anonime – il cosiddetto “corvo” – che lo accusavano di connivenze mai provate. Nel 1989 sfuggì a un attentato all’Addaura, dove fu trovata una carica di esplosivo nei pressi della villa in cui si trovava. Lo definì opera di “menti raffinatissime”. Qualcuno ipotizzò persino che avesse inscenato tutto per fini personali. Accuse infondate che si inserirono in un clima di sfiducia, il cosiddetto “palazzo dei veleni”.
Il Csm gli preferì Antonino Meli alla guida dell’ufficio istruzione. Dopo un breve periodo in Procura – condiviso con Borsellino – nel 1991 passò al Ministero. Pochi mesi prima di morire, commentando la sentenza definitiva del maxiprocesso, Falcone disse: “Ora viene il peggio”. Aveva previsto ciò che sarebbe accaduto: 57 giorni dopo Falcone toccherà a Borsellino. Il copione era già noto.
Anche quest’anno, il 23 maggio, Palermo si è fermata per ricordare. Tante le iniziative per commemorare Falcone, Morvillo e gli uomini della scorta. Migliaia di studentesse e studenti – circa 3.000 – si sono riuniti già dalle 9:30 davanti al Tribunale per l’iniziativa “Tribunale chiama scuola”, promossa dall’Ordine degli avvocati di Palermo, dall’Associazione nazionale magistrati e dalla Rete per la cultura antimafia nella scuola.
Ha aperto le porte anche il “Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, realizzato dalla Fondazione Falcone. Alla cerimonia inaugurale, dalle 9:30, erano presenti il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
Nel pomeriggio, come ogni anno, il cuore della commemorazione si è spostato in via Notarbartolo, davanti all’Albero Falcone. Un minuto di silenzio ha attraversato la folla. Il suono di una tromba ha preceduto il silenzio assoluto, seguito da un lungo applauso. Un momento di intensa emozione, condiviso tra cittadini, istituzioni e associazioni. Quest’anno, tuttavia, il minuto di raccoglimento è stato anticipato alle 17:48, generando alcune polemiche tra i presenti.
Dal palco allestito in via Notarbartolo ha parlato Maria Falcone, sorella del magistrato: “Giovanni ha fatto tantissimo per la lotta alla mafia, ci ha lasciato tutte quelle norme che ancora oggi vengono utilizzate nel combatterla. Io vi ringrazio e vi bacio, perché so che tra di voi, oggi, non ci sono mafiosi, anche se questa città non è ancora libera. C’è ancora tanto da fare”.
Un discorso toccante, che ha rievocato ricordi personali e l’impegno ancora necessario “Quando sono qui in via Notarbartolo – ha aggiunto –, non posso fare a meno di vedere Giovanni uscire da quella porta con i borsoni e i fascicoli. È un’immagine che è scolpita nella mia mente. Quanti politici oggi vanno a cercare il voto sicuro dal mafioso? Quanti arresti, per mafia, ancora oggi vi sono. A chi mi chiede se la morte di mio fratello sia stata inutile io darei due schiaffi, perché non è possibile pensarlo. Quel Giovanni non può essere morto perché, ognuno nella nostra casa, al suo posto, continua ad amarlo, come un fratello”.
A trentatré anni da Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone è più vivo che mai come uomo che ha pagato con la vita il prezzo della verità e della giustizia. Il suo lascito è un patrimonio morale e giuridico ancora oggi fondamentale. La memoria, però, non basta. Come ha ricordato Maria Falcone, “questa città non è ancora libera”. E l’Italia, per onorare davvero quelle vittime, non può permettersi di dimenticarlo.